Raboso, da rabbioso
a domato: Cecchetto
e la rinascita del vino “cattivo” del Veneto
Per anni è stato il vino cattivo del Veneto: ruvido, acido, tannico. Oggi il Raboso Piave non ringhia più: grazie a produttori come Cecchetto si è trasformato in un rosso elegante, identitario e gastronomico. Il vitigno ribelle è diventato un simbolo di territorio, cultura e rinascita enologica
direttore
Per anni era stato considerato il “vino cattivo” del Veneto. Con quella acidità tagliente, i tannini rudi e quella rusticità contadina che faceva scappare molti appassionati. Ma tutto questo appartiene al passato, il Raboso Piave, vitigno autoctono di antica tradizione, da anni sta infatti vivendo una seconda vita: non più il cavallo imbizzarrito della pianura veneta, ma un rosso elegante, identitario, gastronomico. Ci sono ormai puledri di razza, domati e pronti a sfide sempre più ardite, persino per fare bollicine di metodo classico. A guidare questa trasformazione c’è stato un manipolo di produttori visionari. Tra loro, uno spicca per coerenza e caparbietà: Giorgio Cecchetto che conta oggi sull’apporto determinante dei suoi tre figli, Sara, Alberto e Marco.

Una terra difficile, un vitigno testardo
Il Raboso non è mai stato un vino facile. Nasce lungo il Piave, tra Tezze e Oderzo, dove la terra è bagnata dai fiumi e le vigne convivono con nebbie, alluvioni ed escursioni termiche importanti. La sua personalità è ruvida: acidità elevata, tannino presente, profumi di marasca, pepe nero e sottobosco. In passato questa natura “rabbiosa” lo relegava a vino da invecchiamento lungo, da dimenticare in cantina per anni prima che si addolcisse da solo. Ora, invece, un po’ come avviene con i Barolo o i Barbaresco, i tempi sono stati drasticamente ridotti e dopo tre anni ci sono vini pronti per il mercato.
Un percorso enologico in campo e in cantina, fatto per dare valore a un vitigno autoctono e che poteva rischiare di scomparire. Un impegno che si avvicina a quello fatto in altre aree d’Italia dove vini simbolo di territorio sono stati recuperati e rivalutati. Pensiamo solo, in contesti molto diversi, agli esempi di Lagrein, Ciliegiolo, Nerello mascalese, ecc.
La scommessa visionaria di Giorgio Cecchetto
La storia della cantina Cecchetto comincia nel 1968 a Tezze di Piave (Tv). Quella che era una piccola realtà contadina nata su spinta dei genitori mezzadri, diventa un progetto enologico vero negli anni ’80 con Giorgio Cecchetto, diplomato alla scuola enologica di Conegliano. Quando la maggior parte dei produttori sognava di piantare Merlot e Cabernet per inseguire i gusti internazionali, lui decide di puntare tutto sul vitigno più ostinato della zona: il Raboso. Ne studia l’evoluzione in vigna e in cantina e punta su un vigneto tradizionale, la Bellussera, una sorta di pergola alta anche oltre 3 metri, che alla fine si rivela ottimale per salvaguardare l’uva dall’elevata umidità della zona e garantire una vendemmia che può arrivare anche ai primi di novembre.
Tecnica, pazienza e identità: la chiave della metamorfosi
Nel 1994 esce la prima annata con etichetta Cecchetto. È l’inizio di una lunga operazione di addomesticamento intelligente: non snaturare, ma valorizzare. Oggi Cecchetto produce diverse interpretazioni di Raboso, tra cui Gelsaia - un blend tra uve fresche e appassite che anticipa lo stile della Docg - un Raboso Passito che spinge il vitigno verso espressioni quasi da vino da meditazione, e un metodo classico rosé, Rosa Bruna, una scommessa vinta oggi alla grande.
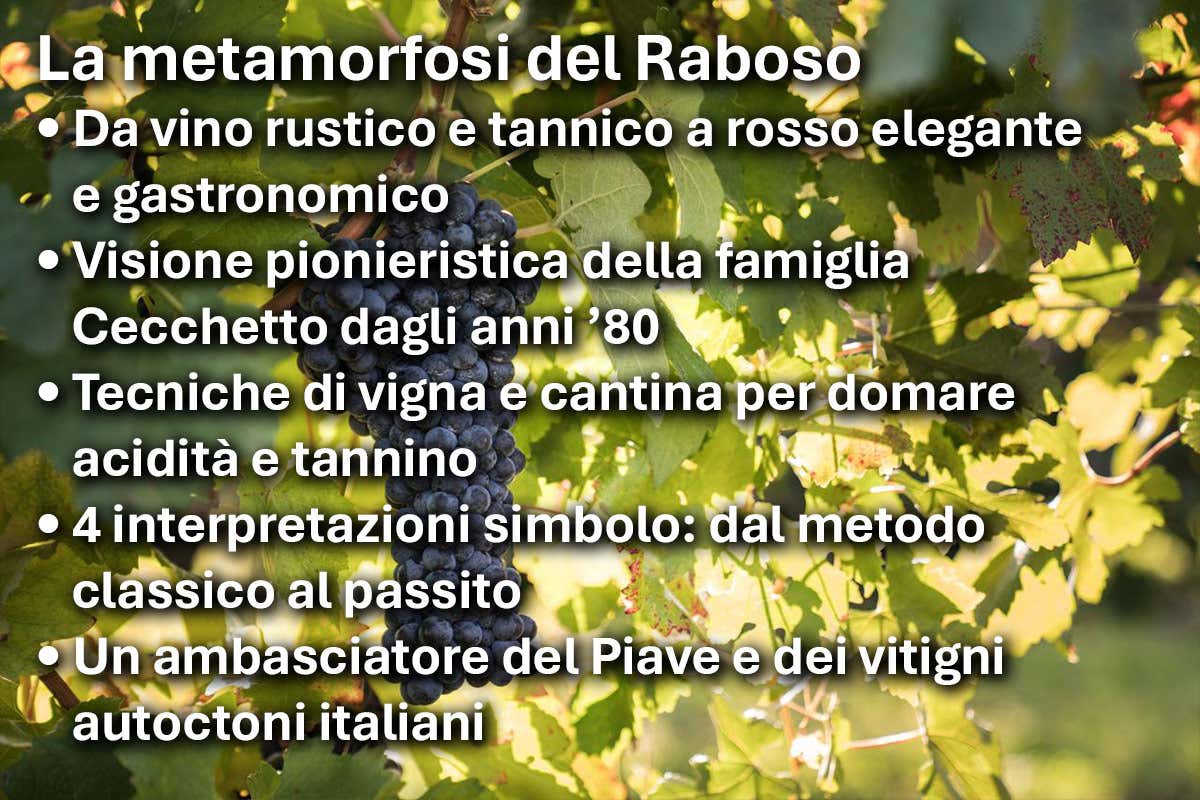
La trasformazione tecnica è la chiave: potature mirate e rese più basse, raccolta calibrata, uso parziale di uve appassite, affinamento intelligente e racconto territoriale forte. Il risultato è un vino che mantiene la sua identità, ma oggi conquista anche chi prima lo temeva. Non è un vino ruffiano, tutt’altro, ma convince per contrasto.

Questa evoluzione non è solo enologica, è culturale. Il Raboso oggi non è più un vino per pochi intenditori, ma un ambasciatore autentico del Piave. Le nuove generazioni di produttori, seguendo la scia di realtà come Cecchetto, stanno ridisegnando il profilo di un vitigno che rischiava l’estinzione commerciale. Affiancando a questo impegno quello per la sostenibilità ambientale e quello per il sostegno a molti progetti di inclusione e solidarietà sociale.
Quattro interpretazioni per raccontare un territorio
E la conferma viene da una degustazione in cui Sara e Marco Cecchetto, la terza generazione in azienda, hanno presentato quattro etichette rappresentative di una produzione della cantina che oggi supera le 300mila bottiglie (fra cui anche Merlot, Cabernet e Prosecco). Ma vediamo nel dettaglio i 4 vini simbolo del nuovo Raboso.
Rosa Bruna Rosato brut metodo classico
Dedicata alla nonna Bruna, questo spumante, colore rosa antico, esce dopo nove anni di affinamento in bottiglia e rappresenta una scommessa vinta per la possibilità di fare del vino ribelle e rabbioso una cascata di bollicine intense, dove acidità, sapidità e piacevolezza si integrano fra loro. Il richiamo a frutti di bosco è sottotraccia e a vincere è la sensazione di pulizia ed eleganza.

La lavorazione in cantina prevede una macerazione a freddo per 12 ore sulle bucce e una successiva vinificazione in bianco come pas dosè. La maturazione sui lieviti potrebbe essere ridotta a 72 mesi, ma certo oggi è un bello spumante che costa franco cantina 16 euro (quasi regalato…).
Raboso del Piave Doc 2022
È l’interpretazione più autentica del Raboso di oggi, un vino di tre anni che sarebbe stato imbevibile tempo fa. Fa tre passaggi in cantina, dall’acciaio alle barrique per 12 mesi. Con un colore rosso rubino intenso, ha un aroma pieno, gradevole e molto fruttato che ricorda frutta rossa come marasche e more. Secco e deciso in bocca ha tannicità, ma domata e resa piacevole da una spiccata acidità. Più che meritati i 16 euro di vendita franco cantina.
Gelsaia Docg 2022
Dopo tre anni, di cui almeno uno in legno (con il 15% delle uve appassito in fruttaio fino a metà dicembre), questo vino assolutamente innovativo (per il territorio e per la storia del Raboso) ha intensi riflessi granati e profumi che rimandano ai grandi vini importanti, con richiami di confettura e cioccolato. Al gusto è vigoroso, ma al tempo stesso fresco e con un tannino ben gestito, che con un affinamento in bottiglia saprà certamente migliorare ancora. Un vino quasi da masticare tanto sa di frutto. I suoi 16 gradi quasi non si sentono, ma è possibile che a breve vengano ridotti attorno ai 13. Per 38 euro franco cantina è certamente un buon investimento.
Raboso passito
Frutto di un assemblaggio di più annate, e comunque fino a sette anni, questo passito si fa con i migliori grappoli, conservati in cassette e in graticci fino ad aprile e poi con macerazione in acciaio e fermentazione in barrique. L’appassimento per oltre sei mesi è la base di un vino che con gli anni di affinamento acquista un bel colore rosso rubino e grazie alla sua spiccata acidità non ha assolutamente nulla di stucchevole. Marasca e vaniglia, insieme al tenore decisamente secco, sono i marcatori di un gusto originale e di cui ci sono pochi eguali. 24 euro il costo franco cantina.
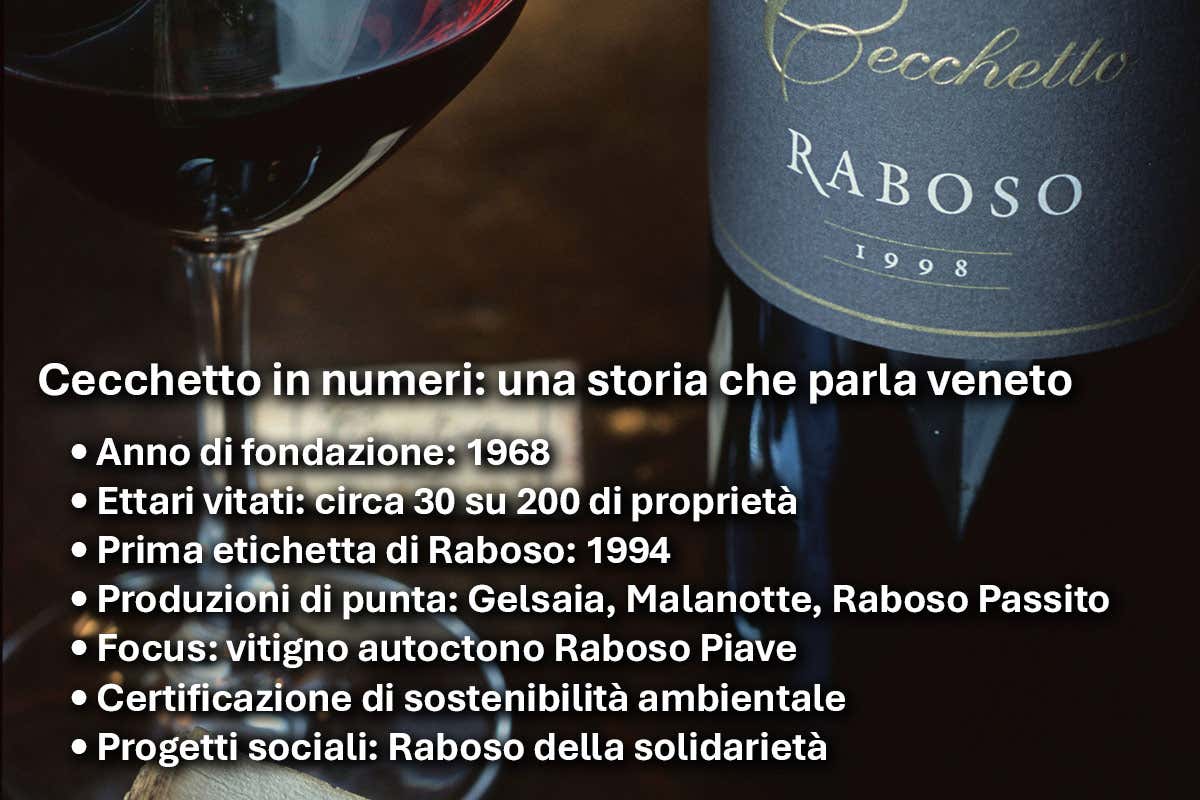
Il Raboso come simbolo culturale e rinascita autoctona
La storia di Cecchetto e del Raboso è, in fondo, una lezione per tutta l’enologia italiana: anche i vitigni più difficili possono trovare una seconda vita se accompagnati con visione e coerenza. Non servono maquillage o addolcimenti furbi: serve ascoltare la natura del vitigno e guidarlo, non combatterlo. Oggi il Raboso non ringhia più. Parla. E lo fa con un accento veneto inconfondibile.







Nessun commento:
Posta un commento