Non chiamatelo più chef: La Mantia è già oltre
Palermitano, oste e ribelle, La Mantia ripensa la ristorazione con scelte fuori dagli schemi: stop ai ristoranti tradizionali e un futuro che guarda a un locale-concept capace di unire cucina, musica e passioni personali. «Il mio mestiere è mettermi al servizio degli altri» racconta, tra provocazioni e riflessioni sul Ponte sullo Stretto e sull'arancina
Un'arancina come pedaggio per attraversare lo Stretto di Messina. La battuta di Filippo La Mantia ha fatto sorridere, ma dietro l'ironia c'è l'anima di un cuoco-oste che ha attraversato mezzo secolo di ristorazione italiana. Oggi, a 65 anni, il palermitano che ha portato i sapori della Sicilia a Roma e Milano non parla solo di ponti o di politica: racconta la sua cucina senza aglio e cipolla, l'addio ai ristoranti e un futuro che immagina come concept, tra cibo, musica, moto e fotografia.
Il ponte sullo Stretto e il futuro della Sicilia
Partiamo dalla sua provocazione: davvero farebbe pagare il ticket del futuro Ponte sullo Stretto con un'arancina?
Purtroppo, o forse per fortuna, ho 65 anni, quindi sono nato in un'epoca - ormai possiamo dire un'era - in cui ognuno di noi poteva parlare, esprimere la propria opinione, anche distruggere i concetti altrui. C'era lo scambio verbale, ci si confrontava, se una cosa non ti andava ci si incontrava e se ne parlava. Oggi invece affrontare qualsiasi argomento è diventato, almeno qui in Italia, automaticamente qualcosa che appartiene o alla sinistra o alla destra. Tutto è ricondotto alla politica, senza pensare che ci sono persone come me che la politica l'hanno vissuta davvero: io ho cucinato a Roma per quindici anni, per tutti, dall'estrema sinistra all'estrema destra, senza mai favorire nessuno. Quello che dico sul ponte è un giudizio personale, che rivendico con orgoglio e senza nessuna influenza politica. Io da siciliano ho preso il traghetto almeno cinquecento volte, da quando ho la patente. E mi sono rotto le scatole di aspettare due, tre ore e mezzo in autostrada per attraversare pochi chilometri di mare. Per questo sostengo il ponte: non perché me lo dice qualcuno, ma perché lo considero necessario per esperienza diretta. Sul traghetto, però, resta un rito: l'arancina la devi mangiare, fa parte dell'esperienza. Quindi, con ironia, ho detto: invece di dieci euro di ticket, mettiamo un'arancina. Anzi, un'arancina e un arancino, così siamo tutti contenti.

E in chiave turistica, secondo lei, il ponte cambierebbe davvero la Sicilia?
Per me sì, e ci metto la firma. Lo dico con convinzione: io lo guardo anche dal lato romantico, perché il traghetto ha un suo fascino, quei 25/30 minuti in mezzo al mare, l'alba o il tramonto, l'arancina in mano. È bello, è un rito. Ma il mondo va avanti. Negli anni '70 e '80 io viaggiavo in moto con la cartina geografica e chiedevo indicazioni alla gente per strada; oggi abbiamo internet, i telefonini, tutto è cambiato. In tutto il mondo hanno costruito ponti che hanno migliorato la mobilità. Qui invece, appena si parla di ponte, partono due miliardi di paranoie. È chiaro che il ponte da solo non basta: intorno ci vogliono infrastrutture, ferrovie veloci, collegamenti rapidi. Non è possibile che da Palermo a Roma ci vogliano 22 ore di treno: quello è un problema delle Ferrovie dello Stato, che non hanno mai fatto una linea decente nella mia terra. Quindi dico: il ponte serve, eccome se serve, ma deve inserirsi in un contesto più ampio. Io sogno di prendere la Salerno-Reggio Calabria e attraversare lo Stretto su un ponte figo, ampio, sicuro. Stop, tutto qui.
Una cucina senza aglio né cipolla
Lasciando l'attualità ed entrando in cucina: lei è famosissimo per una scelta controcorrente, quella di eliminare aglio e cipolla dai suoi piatti, un po' un controsenso per un siciliano. Come è arrivato a questa decisione?
È una scelta che porto avanti da tanti anni: semplicemente non mi piacciono. Quando ho iniziato a cucinare decisi di non usarli, e da lì è nato anche il mio stile. I ristoranti erano sempre pieni, non per autocelebrazione ma perché alla gente piaceva quello che facevo. Ancora oggi, se mi invitano in un resort o in un evento, so che mi chiedono di mettermi ai fornelli: lo faccio per amore, come chi tira fuori la chitarra a una cena tra amici. La mia regola è stata chiara: niente aglio, niente cipolla, ma anche niente porro, scalogno, burro o vino in cottura. Per me il cibo deve avere identità: se mangio un pesce, deve sapere di pesce, non essere coperto da altri sapori. Lo stesso vale per il peperoncino: lo adoro, ma al ristorante non lo uso, a meno che il cliente non lo chieda. All'inizio mi presi critiche assurde, qualcuno arrivò a dire che era una scelta “berlusconiana”. Non c'era nulla di politico: era solo gusto personale. Col tempo ho scoperto che migliaia di persone non amano aglio e cipolla e nei ristoranti si sentono trascurate. Io ho costruito la mia cucina anche per loro: perché se una cosa non piace, non piace, e il cliente ha diritto di essere rispettato.
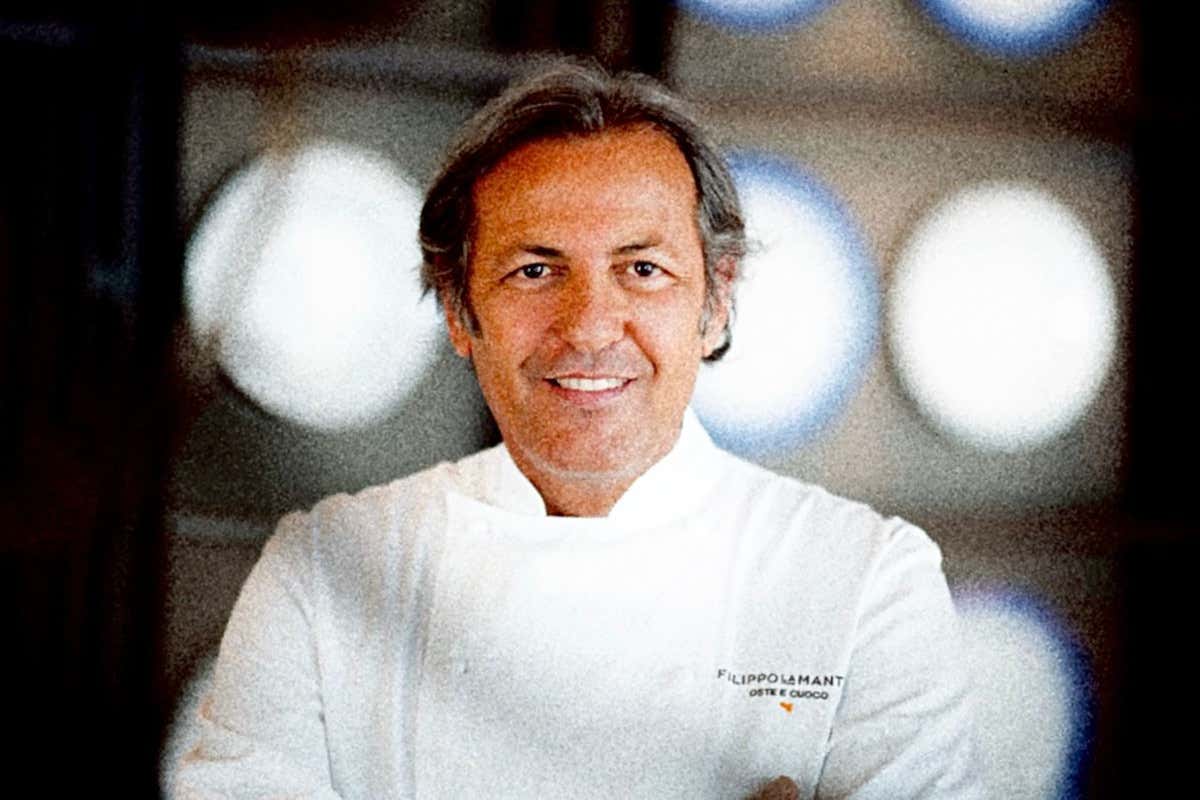
Ma in assenza del soffritto classico, quali ingredienti utilizza?
Uso il succo di lime, che è meno aggressivo, e quando è periodo anche quello d'arancia. Poi la mia cucina è fatta soprattutto di erbe aromatiche: finocchietto selvatico, menta, basilico, origano profumato. In realtà già dagli anni '80 mi sono sempre inventato quelli che chiamo “pesti a crudo”, delle basi fresche che utilizzo per costruire qualsiasi piatto io voglia fare. È da lì che nasce la mia identità in cucina, tutta giocata sulla freschezza e sulla pulizia dei sapori.
E accanto a questa ricerca di freschezza, quanto conta per lei la leggerezza dei piatti in un'epoca in cui molti puntano ancora su ricette ricche e complesse?
Per me è fondamentale. Con tutto il rispetto per chi fa scelte diverse - ed è giusto che ognuno abbia la propria identità e il proprio mondo - io credo che quello che comanda davvero sia il cliente. Se a me un piatto piace ma al cliente non piace, io lo devo modificare. Punto. Il mio piatto non è un'opera d'arte intoccabile, non è la Gioconda o la Pietà di Michelangelo: è cucina, è servizio. Il problema è che spesso, se dici a un cuoco “questo piatto non mi piace”, quello si offende. Ma che senso ha offendersi? Io lavoro per i clienti: se il ristorante non è pieno, non serve a niente che io faccia un piatto solo per il mio gusto personale. Quello me lo posso tenere a casa per i miei amici. Se invece decido di aprire un locale, quel locale sarà anche mio ma appartiene soprattutto ai clienti. E quindi la cucina, per me, è altruismo allo stato puro: significa mettersi al servizio degli altri, dare qualcosa che piaccia e che faccia stare bene. È la stessa logica del lavare i piatti o sistemare la cucina: sono tutte parti dello stesso lavoro, dello stesso atto di altruismo che è il nostro mestiere.
L'addio ai ristoranti e la scelta della consulenza
Passando alle esperienze, penso a quella del Mercato Centrale di Milano: che cosa le ha lasciato questo progetto e quali difficoltà ha incontrato?
Al Mercato Centrale ci ho creduto molto: il concept mi piaceva e all'inizio ero motivato. Ma ho capito presto una cosa: il mio pubblico storico, quello che mi seguiva da Roma a Milano, non mi ha seguito lì. Sono venuti all'apertura, poi basta. È stato un segnale forte: a Milano la stazione non è percepita come un luogo accogliente, dove vivere un'esperienza gastronomica. Altrove funziona, qui no. Un limite culturale che ho pagato sulla mia pelle.
Perché ha deciso di lasciare i ristoranti e dedicarsi alla consulenza?
Sono uno della vecchia guardia: ho sempre vissuto il ristorante insieme al mio personale, in ogni dettaglio. L'ultimo locale a Piazza Risorgimento mi ha dato grandi soddisfazioni ma anche molte fatiche. Poi è arrivato il Covid: non mi sono fermato, ho fatto centinaia di consegne personalmente, persino fino a Torino e Bologna, anche 150 al giorno. È stata un'esperienza incredibile, che mi ha fatto capire quanto la mia cucina funzionasse anche nel delivery. Il problema è nato con la riapertura: in sala e in cucina ho trovato un approccio diverso, meno responsabilità e più leggerezza. Al Mercato Centrale avevo 18 dipendenti, ma spesso assenze continue: una domenica mi sono ritrovato da solo a lavare piatti e pavimenti. L'ho fatto con dignità, ma a 63 anni mi sono chiesto se avesse senso. Così ho deciso di non gestire più ristoranti: oggi mi dedico alla consulenza, che mi permette di cucinare, trasmettere idee e costruire progetti, senza il peso della gestione quotidiana.

E com'è cambiato il suo approccio creativo rispetto a quando era imprenditore in prima linea?
Quello che mi manca davvero è il palcoscenico. Mi manca perché so che anche alla gente manco: lo percepisco da quello che mi dicono i clienti, che per me restano il punto di riferimento assoluto. Io sono, in fondo, una creatura dei miei clienti: so fare le cose che piacciono a loro e il mio lavoro ha senso solo se c'è qualcuno che le apprezza. Ma intorno a un piatto non c'è solo la cucina: c'è l'accoglienza, l'atmosfera, il sorriso, la capacità di lasciare i problemi fuori dalla porta. Devi far sentire il cliente a casa sua, dargli l'impressione di essere al centro di tutto. Io, per esempio, ero uno che se vedeva un piatto non gradito al cliente, non lo faceva pagare. Oppure pensi al mio buffet: una sessantina di piatti diversi che uscivano in continuazione, a Milano, a 30 euro a persona. Una follia, forse, ma io ragionavo così: lavorare per la gente. Questa parte scenica, questa possibilità di esibirmi, mi manca come a tanti altri cuochi che hanno fatto la stessa scelta. Ma non mi lamento: ringraziando Dio faccio ancora tantissimi eventi durante l'anno, seguo consulenze importanti, soprattutto all'estero, e quindi non mi annoio di certo. Anzi, in questo momento i miei avvocati stanno valutando tre proposte da parte di gruppi che mi hanno contattato. In questi due anni ho incontrato tante realtà, ne ho cercate anch'io, e ho scoperto che anche se hai un nome e un seguito, quando chiedi qualcosa spesso la risposta è un no secco.
Il sogno di un nuovo locale-concept
E ad oggi qual è stato il progetto di consulenza più stimolante che ha seguito?
Ho lavorato per circa otto mesi a Tirana. Ci sono arrivato perché il Premier albanese era stato mio cliente a Milano: tramite amici comuni e sapendo che non avevo più un ristorante, si è presentata l'occasione di andare in Albania e dare una mano. Ho collaborato con alcuni imprenditori che stavano investendo nella ristorazione, aiutandoli a costruire un modello ispirato all'Italia. Lì l'italianità è un valore assoluto: parlano tutti italiano, seguono le mode italiane, vengono spesso nel nostro Paese. Basti pensare che ogni giorno ci sono decine di voli da Tirana verso Milano, Bologna, Roma, Torino, Catania. Il mio compito era spiegare come funziona davvero la ristorazione in Italia, dalle descrizioni dei piatti fino all'organizzazione di un locale. È stata un'esperienza positiva e stimolante, anche perché ho trovato una città in grande crescita economica. Detto questo, non mi trasferirei mai a Tirana. Non perché non lo meriti, anzi: ma io sono fortunato ad essere nato in Italia, sono siciliano, e dentro di me sento che l'ultimo grande progetto della mia vita vorrei realizzarlo nella mia terra.
Ma se oggi dovesse riaprire un locale, alla luce di tutto ciò, come sarebbe?
Ho le idee chiarissime. In questo momento sto parlando con tre realtà imprenditoriali e con una di loro, al 99,9%, credo che ci sarà un accordo. Mi sono dato tempo fino a settembre per decidere. Se dovessi riaprire, però, non lo farei più con la formula classica del ristorante con tavoli e sedie. Non mi interessa più. Il mio sogno è un luogo diverso: una sorta di concept che non sia solo cucina e vino, ma anche atmosfera, passioni, mondi che mi appartengono. Dentro ci vedo le mie motociclette, la musica rock, la fotografia. Uno spazio che abbracci davvero chi sono io. Certo, ci sarà anche il cibo - non è che uno spaghetto alla Norma cambi se lo servi su un tavolo basso o su uno tradizionale - ma l'idea è di creare un posto informale, dove la gente possa mangiare, ascoltare musica, leggere, condividere esperienze. Un luogo vivo, con più anime, che vada oltre la semplice dimensione del ristorante. Quello, oggi, sarebbe il mio sogno.
Ma si può sapere quali sono queste tre entità o preferisce restare ancora nel riserbo?
Posso dire che le città in cui mi piacerebbe tornare in gioco sono tre: la Sicilia, Bergamo e Milano.
L'oste-cuoco come filosofia di vita
Entrando un po' di più nella sua persona: cosa significa per lei essere “oste-cuoco” e come si può tradurre in un locale contemporaneo?
Ovunque ho lavorato - dalla Costa Smeralda al Majestic di Roma, che considero uno dei progetti più importanti della mia carriera e di cui ancora oggi si parla per i numeri incredibili che ha fatto - ho sempre portato avanti lo stesso concetto: quello dell'oste-cuoco. Una figura che oggi tanti colleghi stanno riscoprendo. Basti vedere quanti chef stellati hanno deciso di rinunciare alla Stella per aprire osterie, o il successo enorme di progetti come Trippa a Milano. Per me non è mai stata una moda, ma una filosofia di vita. Da ragazzo, a Palermo, frequentavo le osterie di borgata. Io non bevevo vino, prendevo la spuma, ma insieme ti servivano l'uovo sodo, le verdure, le fave. L'oste faceva tutto: ti accoglieva, ti faceva accomodare, ti raccontava cosa aveva preparato, cucinava, portava il piatto a tavola, serviva da bere, presentava il conto e ti accompagnava alla porta. Era un lavoro totale, a 360 gradi. Io sono cresciuto con questa figura, per me quasi mitologica, come quella del contadino. E così ho costruito il mio mestiere: non solo come cucina, ma come modo di vivere. Nei miei ristoranti non mi sono mai limitato a stare dietro ai fornelli. Io entravo e uscivo dalla cucina, accoglievo i clienti, servivo ai tavoli, sparecchiavo, prendevo le comande. Per me il cuoco è questo: un ruolo senza confini, che abbraccia tutto. E solo vivendo il mestiere a 360 gradi puoi davvero capirlo.

Oggi c'è un ingrediente o un piatto che vorrebbe riportare in auge in chiave moderna? Ovviamente siciliano...
La vera genialità del contadino - e io penso soprattutto a quello siciliano - è sempre stata quella di sapersi inventare qualcosa anche in mancanza della materia prima. Di illudersi, in un certo senso, di avere a tavola un piatto che in realtà non c'era. La simbologia perfetta di questo meccanismo, per me, è il cosiddetto pesce di terra. Basta nominarlo per far scattare l'immaginazione: pensi subito a un pesce vero, a un animale che esce dall'acqua per respirare nell'aria. In realtà il pesce di terra è solo un'illusione: non c'è pesce, ma l'idea del pesce. I contadini prendevano i finocchi femmina, più allungati e teneri, li tagliavano a quarti, li sbollentavano appena, poi li passavano nella pastella e li friggevano. Una volta in tavola, avevano la forma e l'aspetto di un pesce fritto. Ecco, per me questa è la modernità assoluta a tavola: illudersi di avere qualcosa e, mangiandolo, far sì che la mente lo trasformi in quello che desideri. È un gioco di immaginazione e di identità insieme, ed è favoloso.
Palermo, le radici e la lotta allo spreco
Per un siciliano la propria terra resta sempre un punto di riferimento: quanto conta Palermo oggi nella sua identità, sia professionale che personale? E quale ricordo d'infanzia porta ancora con sé e ritroviamo nei suoi piatti?
È ovvio che sono orgoglioso - e direi fortunato - di essere nato a Palermo, soprattutto negli anni '60. In quegli anni le famiglie avevano un rapporto straordinario con la tavola e con il cibo: l'appartenenza passava anche da lì. Io, per dieci anni, ho fatto il fotoreporter con Letizia Battaglia, e grazie a quel lavoro ho avuto l'opportunità di entrare dentro le case più povere dei quartieri disastrati di Palermo negli anni '70. Ed è stato quello, più ancora dell'esperienza in famiglia, a segnarmi per sempre. Mia madre e mia nonna cucinavano benissimo, come quasi tutte le donne siciliane, ma il mio stupore vero nacque davanti a quelle donne che avevano pochissimo, con i figli che dormivano nei cassetti dei comò - scene che ho fotografato e che oggi sto recuperando per mostre sul mio archivio - eppure riuscivano a creare piatti meravigliosi. Andavano nei mercati, all'Albergheria, al Capo, a raccogliere i rimasugli dei macellai, dei salumieri, dei pescivendoli. Con scarti che chiunque avrebbe buttato, loro portavano a tavola ricette straordinarie. Quella era la vera arte della nutrizione. Da lì è nato tutto il mio pensiero sulla cucina: l'idea che nulla vada sprecato, che con intelligenza e sensibilità si possa trasformare il poco in tanto. È per questo che oggi sono ambasciatore dell'antispreco al Parlamento europeo e che da anni porto avanti battaglie su questo tema. In ristorante, persino, controllavo i secchi della spazzatura: non per recuperare, sia chiaro, ma per richiamare i miei stessi ragazzi, anche quelli che venivano da Paesi poveri e che qui, trovandosi con la “pancetta piena”, finivano per buttare via cose che io stesso mi sarei portato a casa per cena. Per me lo spreco è il male assoluto del nostro tempo, il vero nemico da combattere. Palermo mi ha insegnato questo: il valore del cibo non sta nella ricchezza degli ingredienti, ma nella capacità di dare dignità anche a ciò che sembra inutile.
Insegnare ai giovani e il valore dell'accoglienza
Ha spesso parlato del valore dell'identità e del rispetto per i clienti. In questo senso, come pensa che la sua esperienza possa aiutare a far crescere i nuovi talenti della ristorazione?
Tra poche settimane inizierò a insegnare all'Italian Food Academy. Era un progetto che mi proponevano da tempo, ma solo adesso ho accettato, perché credo sia il momento giusto. Io non mi considero un professore, ma un narratore: non posso insegnare tecnicamente a cucinare, però posso trasmettere un approccio, un modo di intendere questo lavoro. Nella mia carriera sono passati dalle mie cucine centinaia di cuochi che oggi riconoscono di aver imparato molto da me, e questo per me vale più di qualsiasi titolo. Ho chiesto che le lezioni non siano rivolte solo ai futuri cuochi, ma anche a chi farà sala o persino lavaggio: figure spesso dimenticate, ma fondamentali. In Italia, purtroppo, c'è ancora l'idea che certi ruoli siano di “serie B” o mortificanti, mentre all'estero vengono vissuti con dignità. Il mio obiettivo è trasmettere ai ragazzi il fascino di questa professione, ricordare loro che siamo italiani e che l'accoglienza fa parte del nostro dna. Ogni regione ha una forza identitaria enorme: non dobbiamo inventarci nulla, dobbiamo solo valorizzare ciò che siamo. Questo è quello che voglio insegnare: la passione, l'orgoglio e la responsabilità che comporta fare ristorazione.

Beneficenza muta e responsabilità del cibo
La sua vita privata, sin dagli inizi, è spesso finita sotto i riflettori. Come vive oggi questa attenzione, anche in relazione al rapporto con Marina Di Guardo? E che ruolo hanno per lei gli affetti e le ispirazioni personali nella creatività in cucina?
Io ho sempre cercato di tenere la mia vita privata al di là di tutto. Se qualcuno scrive o immagina cose, fa parte del loro lavoro, ma a me non interessa: non cedo alle provocazioni e non appartengo a quel mondo. Non ho mai criticato nessuno e non lo farò mai: ognuno nella vita è libero di fare ciò che vuole. Io preferisco concentrarmi su quello che può servire davvero alle persone che hanno bisogno. Da vent'anni mi occupo di solidarietà: bambini, detenuti, situazioni di guerra. Recentemente sono stato inserito nel tavolo di lavoro di "Food for Gaza" e per me è stato un grande onore. Avrei voluto andare di persona, e porto sempre il passaporto con me per essere pronto a partire, ma so che non ci sono ancora le condizioni di sicurezza. Questa per me è la vera essenza: dare agli altri. Racconto un episodio: l'anno scorso ho cucinato per una cena di beneficenza a favore dell'oncologia infantile, 350 persone. Mi dissero che lo chef dell'edizione precedente aveva chiesto 20.000 euro: io ho risposto che la beneficenza non si fa con i budget, si fa con il cuore. Perché la beneficenza, quella vera, è gratuita e silenziosa. Se vuole comunicarla l'associazione, ben venga, ma io non lo farò mai. Questo è ciò che mi interessa: non i riflettori, ma fare la mia parte per gli altri. Gli affetti e i valori personali, più che ispirare la mia cucina, guidano il mio modo di vivere.
Il cibo come messaggio universale di responsabilità
Alla luce di tutto quello che ha raccontato - dalle esperienze professionali alla sua vocazione per l'aiuto agli altri - qual è il messaggio più importante che oggi vuole trasmettere, anche e soprattutto attraverso il cibo?
Il cibo è uno strumento di comunicazione potentissimo, nasce per nutrire le persone ed è un diritto universale. Eppure ci sono Paesi in cui ancora oggi la gente non mangia: penso a Gaza, o a ciò che ho visto l'anno scorso in Congo, a Kinshasa. Lì la dignità umana è annullata: bambini scheletrici, anziani ridotti a nulla. Ti rendi conto che siamo davvero delle merde, perdonatemi il termine, se accettiamo che questo accada. Io so che la vita deve andare avanti, abbiamo i nostri figli, i nostri problemi, ma ritagliarsi del tempo per aiutare gli altri è fondamentale. Lo faccio perché è qualcosa che sento dentro, che mia madre mi ha insegnato fin da piccolo. E oggi vedo mia figlia di 18 anni fare lo stesso, andare nelle favelas del Perù, impegnarsi nei progetti di solidarietà. Questo è il messaggio che voglio trasmettere: il cibo non è solo piacere o creatività, è condivisione, responsabilità e un modo per restituire agli altri. Aiutare chi ha meno non è un optional, è un dovere.
La cucina è condivisione, non vanità
Per La Mantia, dunque, il cibo resta un atto di altruismo e responsabilità, prima che di creatività. «Non è arte, non è vanità: è condivisione» dice lo chef che ha fatto della leggerezza e dell'accoglienza una filosofia. È da qui che ripartirà il suo prossimo progetto: non un ristorante, ma un luogo vivo, dove mangiare significhi anche ascoltare, immaginare, condividere. Perché per lui la cucina non è mai stata un mestiere: è sempre stata la vita stessa.
La biografia di Filippo La Mantia
Nato in una grande famiglia a Palermo, nel 1960, La Mantia si è avvicinato alla cucina per necessità, ma da giovane ha seguito la vocazione del fotoreporter: le sue immagini dell'omicidio del generale Dalla Chiesa fecero il giro del mondo. La carriera si interruppe bruscamente con un errore giudiziario che lo portò in carcere per sei mesi, prima della scarcerazione firmata da Giovanni Falcone. Proprio lì scoprì la cucina, trasformandola nella sua nuova vita.
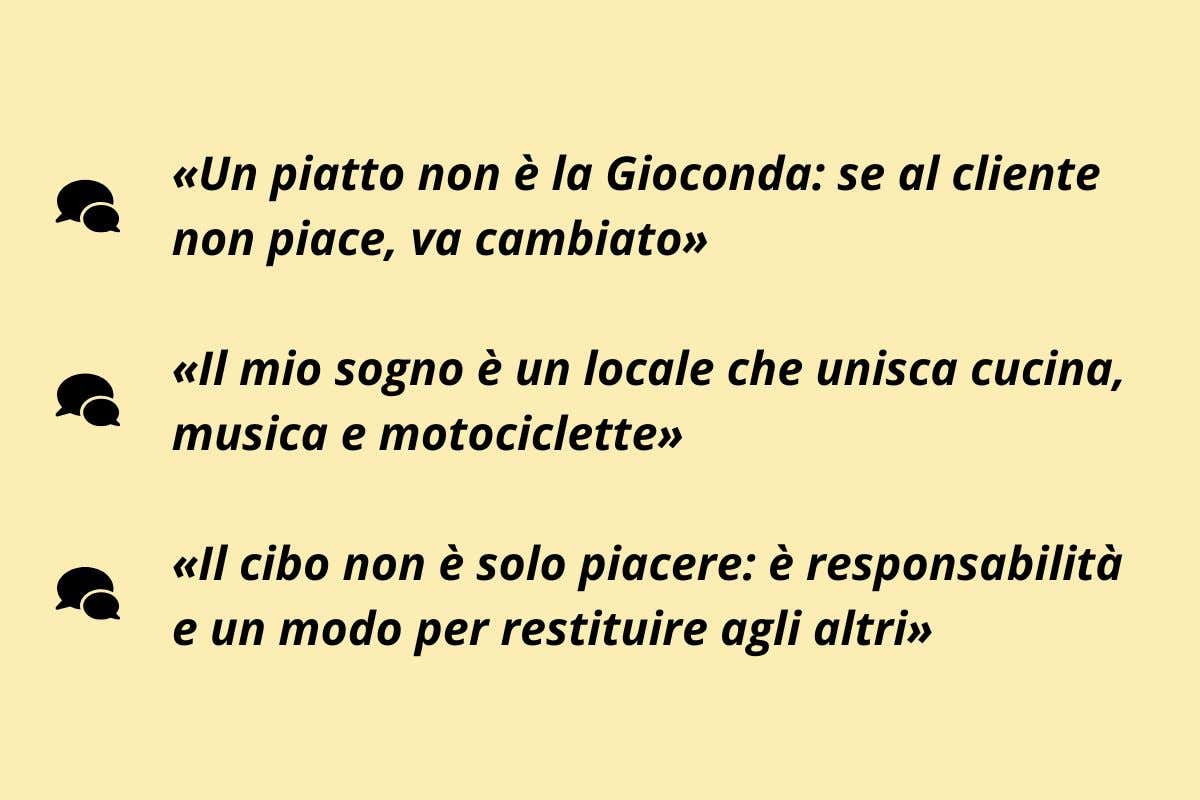
Dopo la prima esperienza con la Zagara, ha aperto ristoranti e collaborato a progetti tra Roma, Milano, Porto Cervo e l'Indonesia, diventando un punto di riferimento della ristorazione italiana. Con il Covid ha chiuso i locali e oggi si dedica a consulenze, progetti di formazione e sensibilizzazione contro lo spreco alimentare, di cui è ambasciatore in Europa. La sua vita privata è stata spesso sotto i riflettori: dal matrimonio con Stefania Scaranti è nata la figlia Carolina; dalla lunga relazione con la food blogger Chiara Maci è arrivato Andrea. Oggi i media raccontano la nuova storia con Marina Di Guardo, scrittrice e madre di Chiara Ferragni.


Nessun commento:
Posta un commento